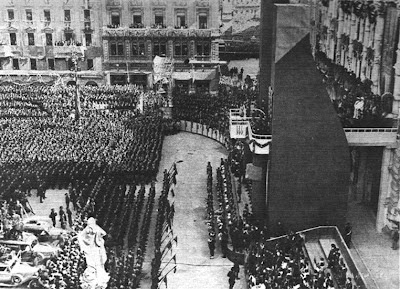Wahrlich
Für Anna Achmatova
Wenn es ein Wort nie verschlagen hat,
und ich sage es euch,
wer bloß sich zu helfen weiß
und mit den Worten -
dem ist nicht zu helfen.
Über den kurzen Weg nicht
und nicht über den langen.
Einen einzigen Satz haltbar zu machen,
auszuhalten in dem Bimbam von Worten.
Es schreibt diesen Satz keiner,
der nicht unterschreibt.
Ingeborg Bachmann
1965
Veramente
Per Anna Achmatova
Se non è mai rimasto interdetto da una parola,
vi dico,
chi non sa che aiutarsi da sé
e con le parole -
non può essere aiutato.
Non sbrigativamente
né con l'aiuto del tempo.
Far durare una sola frase,
resistere alla fantasmagoria delle parole.
Questa frase non la scrive nessuno
se prima non la sottoscrive.
Ich erwähne das alles nicht, um ein Urteil über die einzelnen Dichter und ihre Irrtümer, ihre Einseitigkeiten zu verunmöglichen. Sondern um zu erinnern, wenn man sich heute desorientiert fragt, wie wohl das Neue, wie wohl das Austreten eines wirklichen Dichters und einer Dichtung zu erkennen sei. Es wird zu erkennen sein an einer neuen gesamten Definition, an Gesetzgebung, an dem geheimen oder ausgesprochenen Vortrag eines unausweichlichen Denkens.
Zeitlos freilich sind nur die Bilder. Das Denken, der Zeit verhaftet, verfällt auch wieder der Zeit. Aber weil es verfällt, eben deshalb muß unser Denken neu sein, wenn es echt sein und etwas bewirken will.
Ingeborg Bachmann, Fragen und Scheinfragen, Frankfurter Vorlesung, 1959
Menziono tutto questo non per rendere impossibile un giudizio sui singoli poeti e sui loro errori, sulle loro parzialità, bensì per ricordare, quando oggi ci si chiede, disorientati, come si possa riconoscere il nuovo, l'arrivo di un vero poeta e di una vera poesia, che li si riconosce da una nuova definizione globale, da una legge, riportando, implicitamente o esplicitamente, un pensiero ineludibile.
Senza tempo restano certamente solo le immagini. Il pensiero, ancorato al tempo, è reclamato dal tempo, ma siccome ne diviene succube, proprio per questo il nostro pensiero deve rinnovarsi, se vuole essere autentico e ottenere qualche effetto.
*
Смерть поэта
I
Как птица мне ответит эхо.
Б. П.
Умолк вчера неповторимый голос,
И нас покинул собеседник рощ.
Он превратился в жизнь дающий колос
Или в тончайший, им воспетый дождь.
И все цветы, что только есть на свете,
Навстречу этой смерти расцвели.
Но сразу стало тихо на планете,
Носящей имя скромное... Земли.
Анна Ахматова
1960
La morte del poeta
I
Как птица мне ответит эхо.
B. P.
Ieri una voce unica si tacque,
ci ha lasciati l'interlocutore delle selve.
Si è mutato nella spiga che dà vita
o nella pioggerella da lui cantata.
E tutti i fiori che ci sono al mondo
incontro a questa morte sono sbocciati.
Ma di colpo ci fu silenzio sul pianeta
che ha un modesto nome... Terra.
Anna Achmatova
traduzione di Carlo Riccio
*
Всё сбылось
Дороги превратились в кашу.
Я пробираюсь в стороне.
Я с глиной лед, как тесто квашу,
Плетусь по жидкой размазне.
Крикливо пролетает сойка
Пустующим березняком.
Как неготовая постройка,
Он высится порожняком.
Я вижу сквозь его пролеты
Bсю будущую жизнь насквозь.
Bсе до мельчайшей доли сотой
В ней оправдалось и сбылось.
Я в лес вхожу, и мне не к спеху.
Пластами оседает наст.
Как птице, мне ответит эхо,
Мне целый мир дорогу даст.
Среди размокшего суглинка,
Где обнажился голый грунт,
Щебечет птичка под сурдинку
С пробелом в несколько секунд.
Как музыкальную шкатулку,
Ее подслушивает лес,
Подхватывает голос гулко
И долго ждет, чтоб звук исчез.
Тогда я слышу, как верст за пять,
У дальних землемерных вех
Хрустят шаги, с деревьев капит
И шлепается снег со стрех.
Борис Пастернак
1958
Everything came true
The roads have weathered into gruel
And I must turn aside and go
And plash along a different path
And through the paste-ice, soft as dough.
A jay flies screeching overhead
Into a birch grove's emptiness
That, like an uncompleted building,
Uprears itself in nakedness;
And through its archways I can see
My whole life's future course lie bare
For all its small particulars
Are outlined and perfected there.
The snow-crust lies in layers where
I walk the wood unhurriedly.
And echoes give me their reply:
The way ahead grows clear for me.
In patches on the soaking loam
The bare earth is uncovering
While now and then, as seconds pass,
A bird keeps softly twittering
Her music, like a music box,
Until the forest overhears.
Relays it through its hollow throat.
And waits, waits, till it disappears;
Then long I hear how mile on mile
To distant signposts sounds still flow
Of crackling footsteps, dripping trees.
And from the eaves the splash of snow.
Boris Pasternak
Translated by Henry Kamen